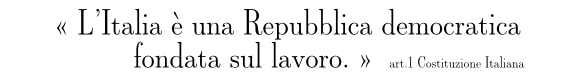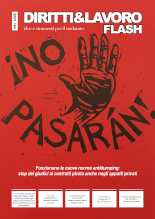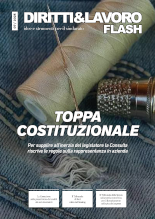Author: admin
Legge di Bilancio 2026: in materia di lavoro e previdenza, poche luci e molte ombre (specie sulle pensioni)
Qualche luce e molte ombre nella Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Tra le prime da segnalare lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, gli incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici madri, il rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori e la proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026. Le seconde riguardano soprattutto (ma non solo) il regime pensionistico. Dal 2027 torna infatti l’aumento automatico dell’età pensionabile (+1 mese nel 2027; +3 mesi complessivi dal 2028) e scompare la proroga per Opzione Donna e Quota 103, per chi non ha maturato i requisiti entro il 2025. Viene anche eliminata la possibilità di utilizzare la previdenza complementare per raggiungere prima l’importo minimo necessario alla pensione. Per promuovere la previdenza complementare, si estende il meccanismo del silenzio‑assenso (entro 6 mesi) per il conferimento del TFR anche ai lavoratori già in forza, non solo ai neoassunti (com’è stato fino ad oggi). Preoccupano anche le misure di detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, perché non viene specificato né il livello della contrattazione né la rappresentatività dei soggetti firmatari: un ennesimo incentivo al dumping contrattuale.
Inammissibile la questione di costituzionalità della legge della Regione Puglia sul salario minimo negli appalti
Respinta la questione di costituzionalità della legge n. 30/24 della Regione Puglia a norma del cui art. 2 comma 1 le stazioni appaltanti regionali sono tenute a verificare che i contratti collettivi applicati dalle aziende aggiudicatarie “prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l’ora” (sentenza n. 188/25 del 16 dicembre). Per i Giudici delle leggi la questione è inammissibile per inconferenza e genericità delle censure proposte dal Governo, che aveva contestato la violazione degli art. 36, comma 1, 39 comma 4 e 117, comma 1, lett. m) Cost. La normativa pugliese infatti non mira a fissare un principio generale in materia salariale, non incide sull’efficacia dei contratti collettivi e non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, dal momento che, riguardando le procedure di evidenza pubblica, incide piuttosto sulla materia della concorrenza. La legittimità costituzionale di leggi regionali che introducono minimi salariali legali negli appalti pubblici resta però sub iudice, visto che pende davanti alla Corte una questione di costituzionalità della legge della regione Toscana n. 30/25, fondata proprio sulla supposta invasione delle competenze statali in materia di concorrenza.
La Corte di Giustizia salva buona parte della direttiva sul salario minimo: respinto quasi in toto il ricorso della Danimarca
La direttiva sui salari minimi adeguati nell’UE è stata salvata dalla Corte di giustizia, che ha respinto quasi integralmente il ricorso per annullamento presentato dalla Danimarca (sentenza 11 novembre 2025, in causa C-19/23). L’unica parte del ricorso accolta riguarda l’elenco dei criteri che, in base all’art. 5.2 della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto considerare nel definire le procedure per determinare e aggiornare il salario minimo legale. Tali criteri infatti determinano per la Corte un’ingerenza diretta nella materia della “retribuzione” che l’art. 153.5 TFUE riserva alla competenza esclusiva degli Stati membri. Lo stesso dicasi per il vincolo (anch’esso eliminato) che impediva ai meccanismi di indicizzazione di determinare una riduzione dei salari. Nulla cambia per l’Italia, dal momento che la norma riguardava i soli paesi dotati di salario minimo legale. Restano rilevanti per il nostro paese gli obblighi di sostegno e promozione della contrattazione collettiva previsti dall’art. 4 della direttiva, che la Corte mantiene in vita. Resterà dunque da valutare non solo se possa ritenersi compatibile con tali obblighi l’attuale sregolato sistema di contrattazione, ma anche se lo saranno i futuri decreti legislativi attuativi della legge delega n. 144/24 relativa alla contrattazione in materia salariale.
Bollettino-7-2025
La Corte costituzionale riscrive le regole sulla rappresentanza sindacale in azienda
Con l’attesissima sentenza n. 156 depositata lo scorso 30 ottobre, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori e identifica nella “rappresentatività comparativa” a livello nazionale un nuovo criterio di selezione dei sindacati titolari del diritto di costituire una RSA in azienda. Vengono così riscritte le regole della rappresentanza sindacale reintroducendo un criterio analogo a quello cancellato dal referendum del 1995, ma ad esso non sovrapponibile. Posto che restano validi i criteri dettati dall’art. 19, come reinterpretato dalla stessa Consulta con la sentenza n. 231 del 2013 (firma del contratto collettivo applicato in azienda e partecipazione alle trattative), si tratta ora di capire in che modo il nuovo criterio possa trovare concreta applicazione, essendo la “rappresentatività comparativa” a livello nazionale concepita nella legislazione vigente per selezionare il CCNL leader di un settore e non per pesare il grado di rappresentatività dei singoli sindacati.
Bollettino-6-2025
Approvata la legge delega che seppellisce il salario minimo legale e attacca la contrattazione collettiva
A quasi due anni dalla sua approvazione alla Camera, lo scorso 23 settembre il Senato ha definitivamente approvato la legge delega in materia di retribuzione e contrattazione (legge 26 settembre 2025, n. 144). Archiviata definitivamente la proposta di introdurre il salario minimo legale, nei principi e criteri direttivi della legge si cela un attacco al sistema di contrattazione collettiva, che si coglie nel superamento della tradizionale nozione di “maggior rappresentatività comparata” per selezionare i c.d. CCNL leader, sostituita da quella di “contratto maggiormente applicato”. Un criterio selettivo che si traduce in un invito alle imprese ad applicare i CCNL più convenienti sul piano economico, rendendoli fonti inderogabili di determinazione dei salari in un determinato settore. Non meno preoccupante è l’indicazione al legislatore delegato di “prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive”: Un giro di parole per indicare l’intenzione di tornare alle gabbie salariali.
Bollettino-5-2025
Sì dalla Consulta al congedo di paternità obbligatorio per la madre “intenzionale” nelle coppie dello stesso sesso
Con la sentenza n. 115 del 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis, d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, madre “intenzionale”, in una coppia di donne risultanti genitori dei registri dello stato civile riconoscendo, di conseguenza, il diritto al congedo anche a quest’ultima. La norma in questione è stata riconosciuta contraria agli articoli 3 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e all’art. 4 della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il quale stabilisce che gli Stati membri riconoscano il diritto al congedo di paternità obbligatorio al secondo genitore equivalente ove riconosciuto nel diritto interno. L’incostituzionalità della norma è per la Corte logica conseguenza del già avvenuto riconoscimento della validità delle trascrizioni nei registri civili italiani degli atti esteri di nascita con indicazione di due madri e risponde all’esigenza di tutelare l’interesse del minore ad avere genitori che se ne prendano cura.